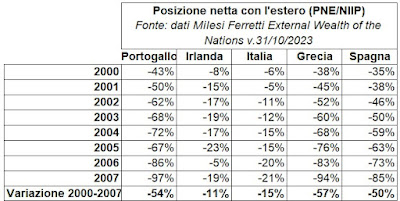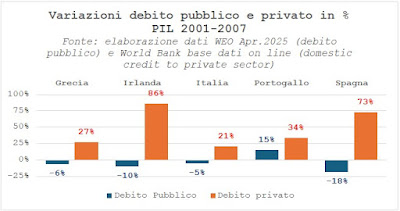L'indipendenza della banca centrale è quel sistema mediante il quale, a tale istituzione, viene concesso il potere di decidere la politica monetaria della nazione senza intromissioni da parte del governo. In questo modo, essa non è obbligata a finanziare le istituzioni pubbliche del paese a cui appartiene, il ché ha come conseguenza spiacevole, ma desiderata, che il governo sia obbligato a piazzare interamente sul mercato privato i titoli pubblici con cui finanzia la spesa in eccesso rispetto alle entrate tributarie, anche se il tasso richiesto dagli investitori dovesse risultare particolarmente elevato e il corrispondente onere per gli interessi molto gravoso.
Questo principio stabilisce la superiorità di giudizio economico da parte del settore privato su quello pubblico e impone che le decisioni di spesa prese dal parlamento secondo il metodo di "una testa-un voto" debbano sottostare alle convenienze degli investitori, che invece condizionano le scelte del mercato secondo il principio, assai meno democratico, di "un euro-un voto". Praticamente, ci vorrà sempre la maggioranza dei parlamentari per approvare una spesa, ma basteranno pochi investitori (i quali però rappresentano la maggioranza dei potenziali acquirenti dei titoli di stato) per far aumentare, anche di molto, il costo dell'indebitamento necessario a finanziare la suddetta spesa. Ed è così che le scelte democratiche vengono sottoposte al giudizio del mercato, il quale tuttavia ha come fine il lucro privato e non il benessere pubblico.
Tuttavia, nonostante la propria indipendenza, la banca centrale non può esimersi del tutto dal comprare i titoli del debito pubblico. Il motivo è tecnico e ce lo spiega il Prof. Cesaratto nel suo bellissimo manuale "Sei lezioni sulla moneta" (Quinta lezione - Come lo stato spende).
Quando le banche commerciali acquistano titoli pubblici dal Ministero del Tesoro li iscrivono all'attivo del proprio bilancio e, per lo stesso ammontare, contabilizzano al passivo il deposito bancario nelle disponibilità del Ministero (che rappresenta un debito per la banca). Il governo però non lascia lì i propri soldi ma li trasferisce subito sul conto deposito presso Banca d'Italia, perché la banca centrale non può fallire ma quelle commerciali invece sì.
 |
| Conto disponibilità del Ministero del Tesoro presso Banca d'Italia (qui) |
Qui arriva la parte importante. Considerate che stiamo parlando di miliardi di euro, e che questo trasferimento, che avviene tramite l'addebitamento del conto deposito degli istituti finanziari presso la banca centrale, fa diminuire le riserve bancarie degli stessi provocando una carenza di risorse nel sistema dei pagamenti interbancari. Già, perché tali riserve costituiscono il mezzo di pagamento per le transazioni fra banche, e tra esse e la banca centrale.
Quindi, se la banca centrale non intervenisse per rimpinguare le casse del sistema finanziario acquistando dalle banche commerciali, sul mercato secondario, parte di quei titoli che esse avevano precedentemente comprato su quello primario, la scarsità di riserve causerebbe un aumento non desiderato, in primis, del tasso d'interesse interbancario e poi, a cascata, di tutti gli altri. Naturalmente, questi titoli saranno poi rivenduti sul mercato quando, al contrario, si verificherà un'abbondanza di riserve rispetto agli obiettivi di politica monetaria che la banca centrale stessa si è autoimposta. Normalmente, questo avviene quando il governo spende i soldi per cui si è indebitato ed essi si trasformano nuovamente in depositi bancari, nelle disponibilità dei beneficiari della spesa pubblica.
La questione, ben nota, emerse anche durante i negoziati per la redazione dello statuto della Banca Centrale Europea. Il comitato dei governatori delle banche centrali (CoG) stabilì che alla BCE fosse vietato di acquistare all'emissione (mercato primario) i titoli pubblici dei paesi aderenti all'euro, per evitare che essa finanziasse in modo diretto uno stato membro. Tuttavia, non le fu impedito di comprarli su quello secondario. Ovviamente, si sapeva che questo limite si poteva eludere ma non fu possibile fare altrimenti, proprio per evitare i problemi precedentemente descritti dal Prof. Cesaratto. I resoconti di quelle riunioni sono raccontati dallo storico dell'economia Harold James, nel suo prezioso lavoro "Making the European Monetary Union" (Capitolo 8: Designing a Central Bank).
 | ||
|
Abbiamo visto che il concetto d'indipendenza dalla banca centrale, in teoria, dovrebbe disincentivare il deficit pubblico, perché il tasso d'intesse richiesto dal mercato per l'indebitamento dello Stato sarà più alto di quello a cui una banca centrale potrebbe acquistare i titoli se fosse obbligata a farlo (cioè se fosse dipendente dal governo). Quindi se il principio dell'indipendenza avesse funzionato come ci viene normalmente raccontato, e cioè come un modo per impedire il finanziamento a costo zero della spesa pubblica, dovremmo riscontrare che, da quando è stato implementato (in Italia, dal "Divorzio" tra banca centrale e il Ministero del Tesoro del 1981) i titoli pubblici detenuti dalla banca centrale siano, in proporzione, molto meno rispetto a quando le allegre spese del governo venivano finanziate monetizzando il debito.
Invece, dai dati di Bankitalia, scopriamo che, non solo nei periodi tranquilli c'è stata poca differenza tra la percentuale di titoli pubblici detenuti dalla banca centrale dipendente e quella indipendente, ma nemmeno in tempi di crisi economica troviamo una sostanziale differenza di questo parametro. Se guardate il grafico qui sotto vedrete che il picco rappresentato dagli anni settanta, quello della crisi petrolifera (e della presunta spesa pubblica incontrollata) è del tutto simile a quello del periodo seguito al "What ever it takes" di Draghi e al Covid, quando Madame Lagarde dichiarò che non era lì per chiudere gli spread salvo poi annunciare il programma di acquisto di titoli pubblici eseguito durante la pandemia (PEEP - Pandemic Emergency Purchase Programme).
Quindi, dai dati sembrerebbe che non faccia poi così tanta differenza l'indipendenza della banca centrale. In realtà la fa perché, normalmente, per poter vendere i titoli sul mercato primario, il governo dovrà comunque offrire tassi più alti (che, come abbiamo visto qui, provocano la crescita del debito pubblico). Tra l'altro, gli interessi pagati dallo Stato alla banca centrale ritornano al governo sottoforma di utili d'esercizio (come abbiamo visto qui) rendendo il finanziamento un prestito a tasso zero.
C'è, infine, un'altra questione. In un paese democratico, una banca centrale dipendente da noi interviene quando glielo diciamo noi, per gli scopi che decidiamo noi. Magari per sostenere la domanda aggregata e l'occupazione in tempi di crisi. Invece, una banca centrale indipendente interviene quando vuole lei e per gli scopi che decide lei. Mentre la BCE indipendente decideva se intervenire sul mercato secondario per sostenere i nostri titoli pubblici, il famoso spread aumentava. E solo a un certo punto Draghi decise che era abbastanza. Al momento dello scoppio della pandemia la situazione richiese un intervento immediato della BCE solo perché, in un momento così grave, l'eventualità che le cose potessero sfuggire di mano metteva a repentaglio l'esistenza stessa del loro prodotto, l'euro.
Quindi, in estrema sintesi, in questo post abbiamo visto che, dai dati storici di Banca d'Italia, non sembra suffragata l'ipotesi che un sistema in cui la banca centrale è dipendente dal governo provoca l'acquisto sconsiderato di titoli per finanziare una spesa pubblica a costo zero, né che, viceversa, una banca centrale indipendente si rifiuti in modo assoluto di intervenire in aiuto del governo in caso di bisogno estremo. Quello che cambia sono i motivi dell'intervento e la sua tempistica. Essi possono essere più favorevoli agli obiettivi della politica quando la banca centrale è espressione della volontà della maggioranza numerica della popolazione, o più conformi alle preferenze degli investitori quando le scelte della banca centrale sono influenzate chi può mobilitare la maggioranza dei capitali.








.JPG)